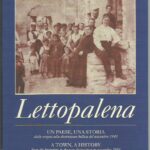UN GIORNALE PULITO AL SERVIZIO DELLA CALABRIA PULITA
Cari lettori, mi accomiato da voi dopo sette anni e mezzo. Non fu una scelta facile quella che feci il 28 novembre scorso quando comunicai all’editore che avrei lasciato il giornale il 1° aprile (poi la data è slittata di due settimane). I motivi erano e sono strettamente familiari, ma ho pensato, come sempre ho fatto nella mia vita, di concludere per tempo un ciclo senza attendere che esso si esaurisse da solo. Aggiungo che, in cuor mio, sapevo che nel giornale era possibile trovare un direttore di valore, che non solo, dunque, fosse un professionista della redazione ma che fosse anche calabrese. Oggi sono felice della decisione dell’editore che affida il Quotidiano nelle mani sicure e pulite di Rocco Valenti, che sono certo risponderà al meglio alle vostre attese e al quale faccio gli auguri più affettuosi. Ma ora che lascio fisicamente il giornale e la Calabria sento una forte emozione, quasi una sofferenza come nei distacchi importanti che la vita ci riserva.
Ho amato e amo questa terra. La conoscevo, non tutta, ma la conoscevo. Ma ora che la conosco forse tutta, mi domando come sia stato possibile concentrare qui tanta bellezza. In ogni angolo, sulle coste, in montagna, nelle città, soprattutto interne, su fiumi e fiumare, negli anfratti più nascosti si rinnova la meraviglia della scoperta. Una sera freddissima d’inverno, poco prima della mezzanotte, telefonai a mia moglie, che era a Napoli e già dormiva, perché avevo il cuore che mi batteva: ero sul lungomare di Reggio, nei pressi della stazione Lido, lo Stretto sembrava inventato, il mare piatto rifletteva le luci di Messina e quasi illuminava Reggio, più in là sulla sinistra, in alto, l’Etna arrossava il buio con tracce di fuoco. Sull’Aspromonte a un tratto ebbi quasi paura, sopra di me alberi secolari non facevano penetrare neanche un filo di luce, ed era un pomeriggio di agosto. Autunno e primavera, la Sila non fa sconti: i colori, quelli delle foglie che muoiono e quelli della natura che rinasce, sono ancora più incredibili del bianco, il non-colore che rende soffice e dolce l’inverno. Non vado oltre, dico solo che ancora resto incantato quando, per la centesima volta, scendo dal Pollino e penetro in questo paradiso. E non parlo dei tesori che nel corso dei millenni gli uomini hanno realizzato. Poi mi chiedo, come fa l’amico Battista Sangineto, se i calabresi sappiano meritarselo questo bendidio.
Un po’ questo è stato il tema del lavoro di questi anni. Tanti ricordi. La valigia non può contenerli tutti. Un grande calabrese, Vincenzo Ziccarelli, mi fece scoprire che Saverio Strati, dimenticato tanto da sembrare morto, viveva nell’indigenza a Scandicci: lo splendore e la miseria, uno schiaffo, ma anche il riscatto grazie a un moto straordinario di opinione e di passione dei suoi conterranei, protagonisti perenni della sua opera. Ad Amantea ci trovammo in ventimila per esprimere il dolore e la rabbia contro chi avvelenava la Calabria: insieme a noi marciava idealmente un altro grande calabrese, il capitano Natale De Grazia, morto “misteriosamente” mentre cercava la verità sulle navi dei veleni. Il sorriso di Lea Garofalo, le tragiche sofferenze di Maria Concetta Cacciola e il coraggio di Giuseppina Pesce attraversarono la Calabria e l’Italia dell’8 Marzo come un vento fresco di speranza. E qualche mese prima quarantamila furono i no alla ‘ndrangheta (“che purtroppo marcia insieme a noi”), ma sul palco salirono solo i testimoni perché i politici – tutti – furono lasciati rigorosamente su un lato della piazza ad ascoltare. Il motivo conduttore è sempre lo stesso: la sollecitazione alla cosiddetta società civile a scendere in campo, a fare la propria parte, a non delegare sempre ad altri e ad assumersi le proprie responsabilità, a sconfiggere, a partire dal proprio impegno, il pregiudizio antimeridionale di cui parla Vito Teti.
La vera rivoluzione è culturale, quella delle coscienze e di un senso comune che si fondi sulle regole, la legalità, la tolleranza e la solidarietà. Cecchino Principe, nel breve periodo dei nostri incontri (è stato uno dei due politici con cui ho pranzato), veniva a trovarmi di proposito per chiedermi di dare spazio alla cultura. Come fa il preside Giovanni Sapia di Rossano, che alla sua veneranda età è un vulcano di rigorose iniziative, tra i primi a sostenere con un convegno la nostra campagna su Sibari, che tra l’altro proprio in questi giorni, grazie al rettore Gino Crisci e al preside Raffaele Perrelli, ha fatto registrare una salutare apertura dell’Università della Calabria verso il territorio. Nella valigia lascio uno spazio per Pier Paolo Pasolini che in una lettera inedita (caro Roberto Losso, che scoop!) sferzò i calabresi (“siete banditi, ma i banditi mi sono simpatici”) invitandoli a “non fare come gli struzzi”. I poeti guardano oltre, sognano per noi, come faceva ogni lunedì padre Giancarlo Bregantini quando toccava il cuore dei calabresi augurando loro una “buona settimana”. Nessuno potrà mai togliermi dalla testa che con la cultura non si vende una copia in più di giornale ma che senza la cultura non si va da nessuna parte.
Ho avuto una grande fortuna. I miei editori, Antonella e Francesco Dodaro, sono persone per bene e non hanno mai interferito nel mio lavoro, il giornale lo hanno sempre letto il giorno dopo. D’altro canto, non sarebbe stato possibile il contrario perché ci saremmo salutati all’istante. Tra tante difficoltà imprenditoriali, con me hanno onorato il patto iniziale di assoluta autonomia. La foto del loro papà – il sorriso di un uomo buono e onesto – mi è diventata familiare, e ho sempre pensato che nella loro attività ci sia stato e ci sia il valore aggiunto di una tragedia, l’assassinio del loro genitore, e della giustizia negata. Per sapere come vanno le cose in Calabria, non ho avuto bisogno di andare molto lontano.
La giustizia, appunto. Ce n’è poca e ce n’è troppa ma a sproposito, perché il sistema presenta deformazioni allarmanti. I secondi gradi, troppo frequentemente, ribaltano le sentenze di primo grado e si resta sgomenti su come il bianco possa diventare improvvisamente nero e viceversa. Sarà una garanzia, ma qualche dubbio rimane. Per non dire di inchieste e processi interminabili che finiscono nel nulla. Puoi marcire in galera se sei un povero diavolo o, da condannato in via definitiva, spassartela a casa se hai potere e soldi. Ma soprattutto c’è qualcosa che ci riguarda in Calabria come in Italia. Nella pratica il rito giudiziario non è formato dai tre gradi, ma c’è questo e prima ancora ce n’è un altro. L’indagine preliminare dei pubblici ministeri, in sé necessaria e inevitabile, si coniuga con l’informazione. In questa fase si determina un meccanismo infernale, che produce la condanna a priori dell’indagato, anche perché gli organi di informazione sono indotti, per scelta o per costrizione, a “sposare” le tesi dell’accusa, le uniche esistenti in quel momento, sia per motivi di concorrenza sia per fugare sospetti di amicizia o compromissione. Quante volte ho sentito persone innocenti lamentarsi per i titoloni a loro dedicati durante l’indagine e per lo spazio esiguo in sede di processo e dopo le sentenze. Noi, soprattutto se siamo in buona fede come dovrebbe essere sempre per deontologia professionale, dobbiamo essere consapevoli del danno che tante volte arrechiamo alle persone. Ciò detto, se non si riforma la giustizia e non si correggono storture così devastanti, cambierà poco e i pm, talvolta tentati dal successo mediatico, continueranno a fare le loro inchieste mentre noi giornalisti amplificheremo il loro lavoro senza poter contrapporre alle loro tesi quelle della difesa, che fino a quel momento non ha avuto alcuna possibilità di agire.
L’altro nodo è quello della politica che invade ogni cosa. Questa degenerazione, asfissiante, scaturisce dalla dipendenza quasi totale della Calabria dal pubblico. All’esercito dei dipendenti pubblici e anche dei rappresentanti istituzionali e degli eletti si deve sommare un altro vastissimo esercito di persone “protette” a vita dallo stato sociale. Se per incanto un giorno lo Stato cessasse di esistere, la Calabria intera finirebbe sul lastrico. In questa composizione sociale, a cui fa da contraltare una classe dirigente di basso profilo e di scarso coraggio, sguazza la politica che non ha bisogno di rendere molto conto del suo operato anche perché tra eletti ed elettori c’è una corrispondenza di sensi, salvo poi tutti a lamentarsi che la Calabria sta male, è governata peggio, conta poco, è abbandonata. Pensare di scappare, come fanno in tanti, appare quasi una scelta naturale per chi non accetta questo stato di cose. Forse così si spiegano la mancanza di tensione sociale e politica e la sostanziale continuità amministrativa e perfino programmatica tra aree politiche sulla carta alternative tra loro. Ed è per questo che risultano eroici gli sforzi di chi resta e suda per fare qualcosa di buono. Ce ne sono tanti, ma sono spesso deboli e isolati e fin quando non riusciranno a fare rete e a cambiare le regole del gioco resteranno marginali e soccombenti.
Tanto per cambiare, non servono eroi ma persone normali e, quindi, normalità. Per quanto impegno militare e di intelligence lo Stato possa mettere in campo, non sarà possibile estirpare la malapianta della ‘ndrangheta ma anche quelle del favoritismo, del clientelismo, del familismo, dell’assistenzialismo, delle regole violate e piegate a proprio uso e consumo. La prima norma è partire da sé stessi prima di chiedere agli altri e domandarsi: che faccio io per gli altri? qual è la cosa giusta da fare? È il primo gradino della scala che porta a cambiare davvero le cose. Ciò vale naturalmente per tutti, anche per chi fa il mio mestiere e ha avuto l’opportunità di dirigere un giornale in Calabria. Cari lettori, mi scuso per gli errori fatti, ma oggi saluto e ringrazio voi e i miei compagni di lavoro – i redattori, i collaboratori, i fotografi, i poligrafici, i segretari e le segretarie di redazione, gli amministrativi, i rotativisti, gli ispettori di distribuzione e i distributori, le correttrici, i pubblicitari – con la coscienza di aver tenuto fede ai principi che vi illustrai il primo marzo 2007. E credo che il Quotidiano continuerà sempre meglio il suo cammino perché – come dice il mio carissimo amico Antonio Panettieri, che solo per caso è un dirigente dell’azienda – la Calabria ha bisogno di un giornale libero e pulito come quello che avete tra le mani. Proteggetelo.
Articolo pubblicato sul Quotidiano della Calabria il 13 aprile 2014